Ci si è interrogati la volta scorsa se davvero il PIL rappresenti la misura selettiva e sintetica più opportuna per descrivere lo stato di benessere economico e sociale di un Paese.
E in effetti il dibattito ha già coinvolto, nei decenni, voci autorevoli di economisti e statisti. (Il Pil è nato nel 1934).
Già Kennedy sottolineava le contraddizioni del sistema economico basato su indicatori puramente numerici: “Il Pil misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani”.
Ma ancora di più, lo stesso “inventore” (Simon Kuznets) già negli anni ’30 avvertiva della rischiosità di affidarsi ad una sola unità di misura di sintesi economica: il PIL non poteva riconoscere gli elementi qualitativi della crescita, ma soprattutto, non poteva individuare le diseguaglianze sociali che si creano nella distribuzione della ricchezza. Il Paese che in termini assoluti cresce, ma aumentando contestualmente il numero di poveri, non può essere considerato un Paese ricco.
Di politiche e indici alternativi ne sono stati proposti molti e tutti con una buona dose di ragione. Dalla well-being economy con il paradosso di Easterlin e il livello di assuefazione al benessere, all’Indicatore MEW di Tobin del 1972, dall’Indicatore ISEW, fino allo Human Development Index delle Nazioni Unite del 1990, e infine gli indicatori dell’OCSE, della Commissione Europea o di Eurostat…
Insomma, si rischierebbe di fare solo un elenco non esaustivo e solo mnemonico.
Rimane tuttavia un problema di fondo: qualunque sia il concetto di benessere individuale e sociale che si prediliga, sarà comunque e sempre più un fenomeno multidimensionale, che contempla aspetti economici e sociali.
Sebbene gli indicatori sintetici avranno sempre un grande impatto mediatico, per loro capacità di semplificare la realtà e stereotipizzare fenomeni complessi, va comunque rilevato che il nostro concetto di “qualità della vita” si sostanzia di sempre più aspetti che esulano dalla nostra capacità di contribuire alla formazione di un reddito nazionale.
Se è vero che “ciò che si misura influisce su ciò che si fa” (Stiglitz), è anche vero che “…non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow Jones, né i successi del Paese sulla base del prodotto interno lordo. Il Pil comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. […] Nel Pil ci sono gli armamenti, le carceri, […] le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle, […] i programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti pericolosi ai nostri bambini”.
Lo diceva Kennedy nel 1968, in un intervento all’università del Kansas.
Sono passati 55 anni da allora. Ho la sensazione che siamo rimasti solo “con un pugno di Pil in mano”.

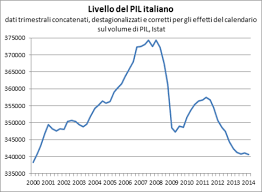
 Elezioni Lombardia, i candidati rispondono
Elezioni Lombardia, i candidati rispondono
E indubbia la ragione addotta riguardo il limite di individuare nel PIL, un indicatore riguardo la qualità della vita della gente.
Casomai il PIL può essere una precondizione necessaria.
Eppure ci sono stati tentativi seri di individuare indicatori (tanti) e diversificatai per area di interesse da parte, per esempio de Il Sole24 h, o dell’Università La Sapienza insieme ad Italia Oggi.
Che cosa pensa l’autore di questi sistemi? Potrebbero essere riuniti ed implementati per trarne riflessioni condivise?